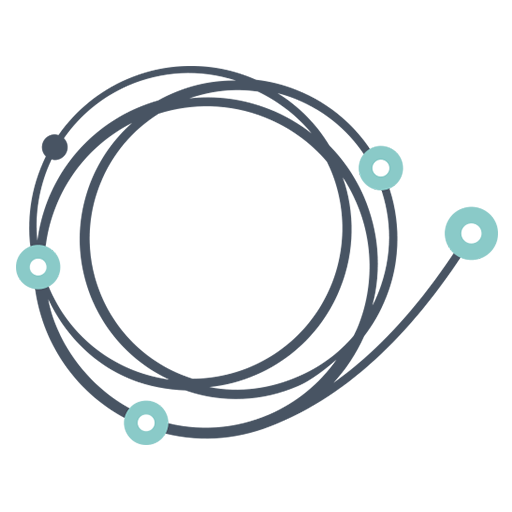Malattia di Alzheimer, verso un sistema diagnostico precoce
21 November 2018 | Scritto da La redazione
Abbiamo intervistato Francesco Tamagnini, docente dell’Università di Reading, con cui abbiamo parlato del futuro della ricerca di questa patologia

Nel 2050 ci saranno oltre 131 milioni di persone nel mondo affette dal morbo di Alzheimer, se la tendenza attuale rimarrà inalterata. Una patologia per la quale, ad oggi, non esistono cure e che è destinata ad avere un impatto sempre maggiore sul sistema sanitario mondiale. Sappiamo ancora poco di questa malattia, scoperta a inizio ‘900 dal neuropatologo tedesco Alois Alzheimer, e gli sforzi degli ultimi anni della comunità scientifica non hanno portato i risultati sperati, nonostante i titoli dei giornali abbiano più volte illuso i pazienti e i loro familiari che la scoperta di una cura fosse vicina.
Per fare un po’ di chiarezza su questa patologia e sull’evolversi della ricerca abbiamo intervistato Francesco Tamagnini, laureato in Biotecnologie Farmaceutiche e dottore di ricerca in Neurofisiologia, dal 2017 professore assistente in Farmacologia alla University of Reading – Reading School of Pharmacy.
Le sue ricerche si concentrano sui correlati cellulari e neuronali delle funzioni cognitive superiori: si occupa cioè di studiare quello che accade nel cervello quando pensiamo e, in particolare, i meccanismi cellulari di memoria e apprendimento. Durante il suo dottorato si è dedicato allo studio del funzionamento del riconoscimento visivo, passando nel corso degli anni all’analisi di questi meccanismi in un sistema affetto da una patologia come la malattia di Alzheimer. Una Junior Fellowship di 3 anni erogata dall’Alzheimer’s Society gli ha permesso di consolidare il proprio percorso di ricerca. Negli ultimi due anni, il suo lavoro si è arricchito di una collaborazione in ambito clinico, finalizzata a convalidare l’elettroencefalografia, l’applicazione di elettrodi sul cervello, come sistema diagnostico precoce per la malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza.
Qual è il vantaggio di questa tecnica diagnostica?
È economica, non invasiva e utilizza delle macchine già presenti nelle strutture ospedaliere. L’obiettivo del progetto, realizzato con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, dove sono nato e cresciuto, l’Istituto Sicurezza Sociale – RSM, l’Università di Exeter e l’Università Tecnica di Monaco, è quello di sviluppare un metodo per prevedere l’insorgere della demenza in persone che mostrano i primi sintomi di deficit cognitivo. La nostra priorità è quella di controllare massicciamente la popolazione, individuando le categorie a rischio: in seguito, sistemi più costosi e, possibilmente, più accurati, come la PET-amiloide, potranno validare la diagnosi. Inoltre, per testare e sviluppare nuovi approcci è necessario individuare i pazienti nelle prime fasi della malattia. Avere diagnosi precoci permetterebbe al sistema sanitario e ai legislatori di prevedere l’impatto della malattia da qui a 20 anni e migliorare quanto più possibile la qualità della vita dei pazienti visto che, ad oggi, una cura non esiste. Infine, una diagnosi precoce e una maggiore stratificazione della popolazione, presumibilmente, permetterebbero alle nuove cure di essere più efficaci.
Proprio a questo proposito facciamo un passo indietro: a che punto è la ricerca sull’Alzheimer?
Le Neuroscienze sono una disciplina giovane, la ricerca sull’Alzheimer è ancora più recente. La malattia è stata identificata nel 1912 ma da allora non è mai stata una di quelle patologie al centro della ricerca mondiale. Almeno fino a tempi relativamente recenti quando, con l’aumento della vita media, sono cresciuti anche i casi di Alzheimer. Il progresso scientifico nella cura di altre patologie, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dell’aspettativa di vita stanno portando a un aumento di persone affette da questa malattia. Per queste ragioni si è iniziato a studiare l’Alzheimer in modo maggiore solo negli ultimi 20-25 anni. E sono pochi, soprattutto per una patologia progressiva. Per studiare l’efficacia di un farmaco servono studi lunghi e costosi che non permettono un output più veloce di quello che si sta avendo. Secondo me un grosso limite è quello di non avere un modello preclinico di demenza sporadica.
Ci spieghi meglio…
Esistono due tipi di Alzheimer, una forma familiare genetica, molto rara. La grande maggioranza dei casi è sporadica, non sappiamo quale sia la causa. Conosciamo dei fattori di rischio, sia di tipo genetico che ambientale, che aumentano la probabilità di contrarre la malattia, ma non sappiamo quale sia il meccanismo fisiologico o patologico alla base. Non conoscendo questo, non abbiamo a livello preclinico un sistema riduzionista della forma sporadica della malattia che ci permetta di valutare sistematicamente l’efficacia delle librerie di farmaci. Quindi lavoriamo con i modelli preclinici di Alzheimer familiare, senza ottenere però i risultati sperati a livello clinico. Per questo motivo sarebbe utile avere diagnosi precoci su pazienti che presentano la forma sporadica, in modo da comprenderne meglio la natura: potremmo scoprire che, come nel caso di alcuni tipi di cancro, non c’è un’unica malattia di Alzheimer ma che ce ne esistono molteplici forme. Questa è la stratificazione a cui facevo riferimento sopra.
Dovremmo quindi parlare di malattie di Alzheimer?
Forse la malattia è stratificata in sottocategorie e se noi non le identifichiamo non possiamo valutare la reale efficacia di un farmaco, che può funzionare per un “tipo” di Alzheimer e non per l’altro.
La strada, quindi, è verso una medicina personalizzata?
La medicina personalizzata è l’estensione dell’idea di stratificazione della malattia di cui parlavo prima. Prendiamo, per esempio, il cancro al seno: se si guardano le mutazioni che lo causano ci si rende facilmente conto che non è una malattia unica. Si è quindi andati a stratificare per categorie, che consentono di sviluppare un approccio terapeutico basato su quella specifica categoria. Andando sempre un passo avanti nella stratificazione si potrebbe, almeno teoricamente, arrivare alla medicina personalizzata. Per l’Alzheimer siamo ancora ad uno stadio precoce. Ora, invece, si sta rivedendo la classificazione dell’Alzheimer e questo potrebbe portare vantaggi importanti.
Che ruolo ha lo studio del DNA nella ricerca sull’Alzheimer?
I primi studi a livello di associazione del genoma, cioè quelli che avevano l’obiettivo di individuare le variazioni genetiche associabili al rischio di contrarre la malattia, hanno portato a un’individuazione chiara di dove siano, a livello di genoma, i fattori che determinano un maggiore rischio di contrarre l’Alzheimer sporadico, ma continuiamo a ignorare i meccanismi che portano queste cause (genetiche) agli esiti clinici. Secondo me dobbiamo abbandonare i modelli causativi lineari (per esempio: battere – infezione – polmonite) e cominciare a considerare queste malattie in modo differente: studiare i meccanismi patologici e fisiologici che legano quel frammento di genoma o quel fattore ambientale alla malattia di Alzheimer così come temperatura ed umidità vengono utilizzate per prevedere le tempeste. Per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal DNA dovremmo avere un modello preclinico di demenza sporadica, che al momento non abbiamo.
I costi legati all’Alzheimer, con aumento della popolazione e l’innalzamento dell’età media, sono destinati ad aumentare. Non sarebbe più conveniente investire di più nella ricerca invece di spendere per cure e assistenza dei pazienti?
Se la tendenza rimane inalterata, secondo un rapporto del 2015 dell’Organizzazione mondiale della sanità, entro il 2050 nel mondo ci saranno circa 131milioni di persone con la demenza. Queste persone, contrariamente a quanto accade con chi contrae altre malattie, hanno un’aspettativa di vita decisamente più lunga: la demenza non uccide. Questo comporta un impatto economico sul sistema sanitario, ma anche per le famiglie, davvero enorme, perché si sviluppa nell’arco di decenni. La spesa sanitaria pubblica nel mondo, sempre stando al rapporto dell’Oms, sarà infatti di 2 trilioni di dollari entro il 2030. La ricerca, quindi, diventa fondamentale. La quantità di soldi investiti è aumentata, ma non è solo una questione di soldi ma, come si diceva prima, di approccio e di “cultura della ricerca”. Ora, dopo il fallimento dei trial clinici, siamo obbligati a cambiare mentalità: è necessario stratificare, sviluppare nuovi modelli preclinici e nuovi metodi di diagnosi precoce. Per farlo sarà fondamentale una maggiore collaborazione nella “filiera” della ricerca.
In che senso?
Oggi la ricerca è piramidale: alla base ci sono i pazienti ed i famigliari, che vivono più o meno passivamente la loro malattia, sopra di loro i medici, che mettono in pratica quanto previsto nei manuali e in cima i ricercatori, chiusi nei loro laboratori. Per invertire la rotta queste tre figure, a mio parere, dovrebbero comunicare di più e cooperare: il ricercatore deve avere un contatto diretto con il paziente ed il medico e la loro esperienza, sia per mettere a fuoco nuove metodologie per la diagnosi e la cura ma anche per trovare soluzioni in grado di migliore la qualità della vita durante il periodo di malattia.